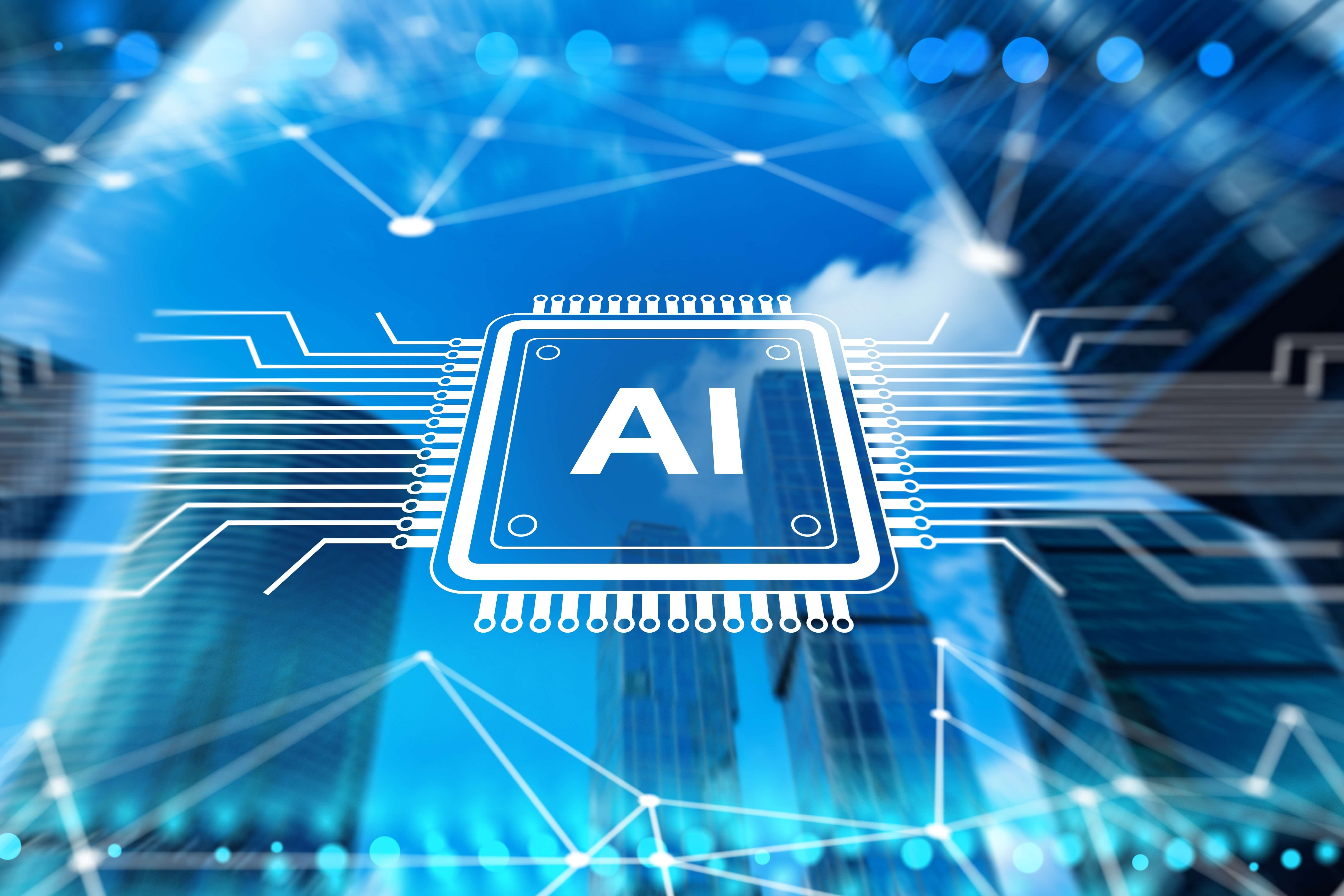L’Intelligenza Artificiale (IA) sta ridefinendo l’architettura cognitiva della sanità moderna. La sua introduzione nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN) rappresenta non soltanto un’evoluzione tecnologica, ma un cambiamento di paradigma nella gestione della salute pubblica, della ricerca e della governance dei dati.
L’Italia, con il suo modello universalistico e con la rete di dati sanitari generata quotidianamente dalle strutture pubbliche e territoriali, dispone di un patrimonio informativo unico che, se opportunamente valorizzato, può diventare la base per un ecosistema di salute digitale sostenibile e inclusivo.
Il presente policy paper delinea un quadro strategico e operativo per l’integrazione sistemica dell’IA nel SSN, in coerenza con gli indirizzi del PNRR – Missione 6 Salute, con il Piano Triennale per la Sanità Digitale 2024–2026, con la proposta europea sullo Spazio Europeo dei Dati Sanitari (EHDS) e con i principi etici dell’OMS e dell’OCSE in materia di digital health governance. Vengono analizzati (in una serie di approfondimenti pubblicati su HealthTech360, ndr) ambiti di applicazione, opportunità, rischi, modelli di governance multilivello, implicazioni etiche e linee operative per costruire una strategia nazionale dell’IA in sanità fondata su trasparenza, interoperabilità, equità e fiducia.
Indice degli argomenti
Una nuova alleanza tra Intelligenza Artificiale e salute pubblica
L’intelligenza artificiale come leva trasformativa del sistema sanitario
L’Intelligenza Artificiale non è una singola tecnologia, ma un insieme di metodologie e sistemi capaci di simulare funzioni cognitive umane – apprendimento, ragionamento, previsione, riconoscimento di pattern – applicandole a grandi moli di dati.
Nel settore sanitario, questa capacità di apprendimento automatico può generare un impatto profondo: dall’elaborazione di immagini radiologiche alla predizione di malattie croniche, dalla pianificazione dei percorsi di cura alla gestione delle risorse umane. La sanità pubblica del XXI secolo non può prescindere da un uso intelligente dei dati: la mole di informazioni cliniche prodotte quotidianamente da ospedali, medici di base, farmacie e dispositivi digitali rappresenta un patrimonio strategico che il SSN deve saper trasformare in conoscenza utile. L’IA costituisce dunque una nuova infrastruttura cognitiva del sistema sanitario, capace di integrare e valorizzare il capitale informativo distribuito sul territorio nazionale.
Il valore del modello universalistico italiano
Il Servizio Sanitario Nazionale italiano, istituito con la legge 833 del 1978, è fondato sul principio dell’universalità e dell’equità nell’accesso alle cure. L’adozione dell’IA in un sistema di sanità pubblica offre una prospettiva unica rispetto ai modelli assicurativi o privati: l’obiettivo non è massimizzare il profitto o la produttività, ma garantire la salute come bene comune.
Ciò implica una governance dell’IA che rispetti la missione originaria del SSN, ossia prendersi cura della persona nella sua totalità, proteggendo i diritti fondamentali e la fiducia collettiva.
Dal digitale alla salute intelligente
Il passaggio dalla digitalizzazione alla vera “intelligenza sanitaria” non è solo tecnologico, ma culturale. Digitalizzare i processi significa informatizzare documenti e procedure; “intelligenziare” la sanità significa, invece, utilizzare algoritmi per generare conoscenza predittiva e decisioni di valore. Questa transizione impone nuove competenze, nuove regole e una nuova etica pubblica, nella quale l’IA diventa alleato del medico, non suo sostituto.
“L’intelligenza artificiale non deve umanizzare la macchina, ma potenziare l’umanità del sistema sanitario.”
Il contesto istituzionale e programmatico
Il quadro nazionale: PNRR e riforme digitali
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dal dispositivo europeo Next Generation EU, rappresenta la più grande occasione di modernizzazione del sistema sanitario italiano dalla sua nascita.
La Missione 6 – Salute destina oltre 15 miliardi di euro a due direttrici fondamentali:
• Componente 1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale: mira a potenziare la medicina di prossimità, con 1.350 Case della Comunità, 400 Ospedali di Comunità e 600 Centrali Operative Territoriali. In questo contesto, l’IA può supportare il monitoraggio remoto dei pazienti, l’analisi predittiva dei bisogni assistenziali e la gestione proattiva della cronicità;
• Componente 2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del SSN: include l’evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 (FSE 2.0), la piena interoperabilità dei sistemi informativi e la valorizzazione dei dati sanitari a fini di ricerca e governance.
In entrambe le componenti, l’IA costituisce una tecnologia abilitante trasversale: i dati raccolti nel FSE, se analizzati con algoritmi validati, possono diventare una fonte di evidenza scientifica per la programmazione sanitaria, la valutazione degli esiti e la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza digitali (LEA-D).
Il Piano Triennale per la Sanità Digitale 2024–2026
Elaborato dal Ministero della Salute e da AgID, il Piano Triennale rappresenta la cornice tecnica e strategica dell’evoluzione digitale del SSN.
I suoi obiettivi principali sono:
• Rafforzare l’interoperabilità e la qualità dei dati sanitari;
• Promuovere l’uso di standard aperti e comuni per i sistemi regionali;
• Potenziare la sicurezza informatica e la protezione dei dati personali;
• Integrare strumenti di IA nei sistemi di supporto decisionale clinico (CDSS);
• Formare le competenze digitali della dirigenza e degli operatori sanitari.
Il Piano riconosce esplicitamente che la trasformazione digitale del SSN deve essere accompagnata da una trasformazione cognitiva, nella quale la capacità di analizzare e interpretare i dati diventa una competenza istituzionale centrale.
Il quadro europeo: Spazio Europeo dei Dati Sanitari (EHDS)
La proposta di regolamento sullo Spazio Europeo dei Dati Sanitari (European Health Data Space), presentata dalla Commissione Europea nel 2022, istituisce un’infrastruttura normativa e tecnologica per la condivisione sicura dei dati sanitari tra Stati membri.
L’EHDS si basa su due assi fondamentali:
• Uso primario dei dati: garantire ai cittadini l’accesso e il controllo sui propri dati sanitari in formato elettronico, promuovendo la portabilità e l’interoperabilità tra sistemi nazionali;
• Uso secondario dei dati: consentire, in forma anonima e controllata, l’utilizzo dei dati per ricerca, innovazione, policy e sanità pubblica
Per l’Italia, la partecipazione all’EHDS significa potenziare la capacità di ricerca, ridurre la frammentazione delle banche dati regionali e allinearsi agli standard europei di qualità e sicurezza. L’integrazione tra FSE 2.0 ed EHDS rappresenta la condizione preliminare per lo sviluppo di una IA trasparente e interoperabile, capace di apprendere da dataset omogenei e di produrre risultati confrontabili a livello continentale.
Iniziative internazionali e quadro OCSE/OMS
L’OMS (World Health Organization), con il documento Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health (2021), ha definito sei principi guida per l’uso etico dell’IA in sanità: protezione dell’autonomia, promozione del benessere, trasparenza, responsabilità, inclusione e sostenibilità.
L’OCSE, con il report AI in the Health Sector: Balancing Innovation and Trust (2023), sottolinea l’importanza di bilanciare l’innovazione tecnologica con la fiducia dei cittadini, evidenziando che l’IA è efficace solo se inserita in un ecosistema di governance affidabile e trasparente.
L’Italia, come membro fondatore di entrambe le istituzioni, ha l’opportunità di tradurre questi principi in una Strategia Nazionale dell’IA per la Salute Pubblica, basata su interoperabilità, etica e cooperazione internazionale.
Le applicazioni dell’Intelligenza Artificiale nel Servizio Sanitario Nazionale
L’applicazione dell’Intelligenza Artificiale nel SSN non è un’ipotesi futura, ma un processo già in corso, seppure ancora frammentato.
Gli algoritmi e i sistemi di apprendimento automatico sono presenti in molteplici aree – dalla diagnostica per immagini alla gestione amministrativa – ma la loro integrazione organica nel sistema nazionale richiede un salto qualitativo: passare da progetti isolati a ecosistemi di innovazione regolata.
Diagnostica per immagini e supporto clinico
L’ambito diagnostico rappresenta oggi la frontiera più avanzata dell’IA sanitaria. Gli algoritmi di deep learning e computer vision hanno raggiunto livelli di accuratezza comparabili, e talvolta superiori, a quelli umani nell’analisi di radiografie, TAC, risonanze magnetiche e mammografie.
Esempi concreti in Italia includono:
• L’uso di reti neurali per la diagnosi precoce di tumori polmonari presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano;
• Sistemi di intelligenza artificiale integrati nel workflow di refertazione del Policlinico Gemelli di Roma per la radiologia muscoloscheletrica;
• Modelli predittivi per la classificazione automatica delle lesioni epatiche all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna;
L’IA non sostituisce il radiologo, ma agisce come strumento di triage e di validazione, riducendo i tempi di analisi e migliorando la capacità di individuare lesioni minime o pattern ricorrenti. L’obiettivo è una collaborazione sinergica uomo-macchina, in cui la tecnologia amplifica la competenza professionale, garantendo maggiore sicurezza e tempestività.
Medicina predittiva e prevenzione
L’IA consente di trasformare il modello sanitario da reattivo a predittivo. Attraverso l’analisi combinata di dati clinici, genetici, ambientali e comportamentali, è possibile individuare fattori di rischio individuali e di popolazione, stimare la probabilità di insorgenza di patologie croniche e orientare strategie di prevenzione personalizzata.
Un esempio significativo è rappresentato dalle applicazioni di machine learning nella prevenzione cardiovascolare: l’integrazione dei dati di pressione arteriosa, colesterolemia, BMI e stili di vita consente di costruire profili predittivi per l’individuazione precoce dei soggetti a rischio. Analoghi modelli vengono sperimentati nel campo del diabete mellito di tipo 2, dove gli algoritmi permettono di anticipare l’insorgenza della malattia e modulare gli interventi terapeutici in modo dinamico.
La medicina predittiva supportata da IA rappresenta un asse strategico anche per le Regioni: il suo utilizzo nei sistemi informativi di popolazione può ridurre il carico sui pronto soccorso, programmare meglio le risorse territoriali e rafforzare la capacità di pianificazione sanitaria.
Telemedicina e assistenza territoriale
L’IA trova applicazione nella gestione intelligente della telemedicina, migliorando la qualità dei servizi a distanza e la continuità assistenziale.
Nel modello delle Case e Ospedali di Comunità, l’IA può:
• Analizzare in tempo reale i parametri vitali dei pazienti cronici;
• Generare alert automatici in caso di anomalie;
• Ottimizzare i percorsi di comunicazione tra medici di base, infermieri di comunità e specialisti ospedalieri.
Un caso emblematico è il progetto “TeleHomeCare Lombardia”, che utilizza sistemi di IA per la gestione integrata dei pazienti fragili a domicilio, con risultati significativi nella riduzione dei ricoveri non programmati.
Analoghe esperienze si stanno diffondendo in Emilia-Romagna e Toscana, dove l’IA viene integrata nelle centrali operative territoriali per gestire in modo predittivo i flussi assistenziali.
Farmacologia, farmacovigilanza e medicina personalizzata
L’AIFA, in linea con le raccomandazioni dell’EMA e della Commissione Europea, sta esplorando l’uso dell’IA per:
• L’analisi automatica dei report di farmacovigilanza;
• La segnalazione precoce di eventi avversi gravi;
• L’ottimizzazione dei percorsi di autorizzazione e monitoraggio dei farmaci innovativi.
La farmacogenomica, potenziata da IA, consente inoltre di correlare variabili genetiche con risposte ai trattamenti, inaugurando una nuova era di terapie personalizzate basate sull’evidenza algoritmica. Questo approccio favorisce la medicina di precisione e riduce sprechi, reazioni avverse e inappropriatezze terapeutiche.
Gestione amministrativa e governance dei dati
L’IA è uno strumento potente anche per la gestione amministrativa del SSN: può analizzare flussi di spesa, prevedere carichi di lavoro, ottimizzare turni e gestire in modo dinamico gli approvvigionamenti. I modelli di predictive analytics consentono, ad esempio, di stimare l’afflusso ai pronto soccorso o la domanda di prestazioni ambulatoriali, migliorando la pianificazione dei servizi.
A livello macro, l’IA applicata ai big data sanitari regionali permette di costruire modelli di governance integrata: analisi predittiva dei fabbisogni, valutazione degli esiti clinici, mappatura delle diseguaglianze territoriali.
Ciò rappresenta un salto di qualità nella programmazione sanitaria basata sui dati (data-driven health policy).
Le opportunità per il Servizio Sanitario Nazionale
L’integrazione dell’IA nel SSN offre vantaggi di natura clinica, economica, organizzativa e sociale. Questi benefici possono essere sintetizzati in quattro grandi direttrici strategiche.
Miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure
L’IA può incrementare l’accuratezza diagnostica, ridurre gli errori clinici e migliorare la qualità complessiva dell’assistenza. Nei reparti di radiologia, l’utilizzo di algoritmi di supporto decisionale consente di evidenziare anomalie che l’occhio umano può trascurare; in oncologia, l’IA aiuta a stratificare i pazienti in base al rischio e a personalizzare i trattamenti. Tutto ciò concorre a un sistema sanitario più sicuro, trasparente e basato sull’evidenza.
Sostenibilità e ottimizzazione delle risorse
Il SSN affronta da anni una crescente pressione economica e organizzativa. L’IA consente di razionalizzare i processi, ridurre i costi evitabili e liberare risorse da reinvestire nella cura diretta. La possibilità di anticipare la domanda sanitaria e ottimizzare la logistica ospedaliera riduce gli sprechi, mentre la previsione dei trend di patologia consente una programmazione sanitaria più efficiente e sostenibile.
Equità territoriale e prossimità digitale
Uno dei grandi obiettivi del PNRR è ridurre i divari regionali. L’IA, se integrata con infrastrutture digitali omogenee, può diventare un fattore di riequilibrio territoriale, portando competenze e servizi anche nelle aree interne e marginali. La telemedicina intelligente e le piattaforme di supporto remoto consentono di superare le barriere geografiche, garantendo a tutti i cittadini accesso alle stesse opportunità diagnostiche e terapeutiche.
Empowerment dei professionisti e innovazione organizzativa
Contrariamente alla percezione di sostituzione tecnologica, l’IA rappresenta un amplificatore di competenze. Può alleggerire i professionisti da compiti ripetitivi e burocratici, restituendo tempo alla relazione medico-paziente. Nella visione di una sanità “aumentata”, la tecnologia diventa strumento per valorizzare il capitale umano, favorendo nuovi modelli organizzativi basati sulla collaborazione interprofessionale e sull’uso condiviso dei dati.
Ricerca, innovazione e partenariato pubblico–privato
L’IA non è soltanto un ambito applicativo, ma un motore di ricerca. L’Italia dispone di un ecosistema scientifico di alto livello – università, IRCCS, centri di ricerca, startup – che può posizionarla come polo europeo di innovazione in sanità digitale. Per raggiungere questo obiettivo, occorre un modello di cooperazione aperta, basato su partenariati pubblico–privati equilibrati e su una visione condivisa della ricerca come bene comune.
Centri di competenza e rete nazionale
È necessario creare una Rete Nazionale di Centri di Competenza per l’IA Sanitaria, che coordini la ricerca applicata e favorisca il trasferimento tecnologico.
Questi centri, localizzati preferibilmente presso IRCCS e poli universitari, dovrebbero occuparsi di:
• Sviluppo e validazione di algoritmi clinici;
• Progettazione di sistemi di supporto decisionale;
• Standardizzazione dei dataset di addestramento;
• Formazione dei professionisti sanitari e tecnici;
• Analisi di impatto economico e sociale.
Una rete così strutturata potrebbe operare in sinergia con i centri europei previsti dal programma Digital Europe, garantendo l’accesso a finanziamenti comunitari e a partnership di ricerca transnazionali.
Il ruolo del partenariato pubblico–privato
Il contributo del settore privato è fondamentale per accelerare lo sviluppo dell’IA, ma deve essere regolato da meccanismi di governance pubblica dei dati. Le collaborazioni tra imprese tecnologiche e strutture sanitarie devono rispettare criteri di trasparenza, neutralità e equa ripartizione del valore. Il dato sanitario, anche quando anonimizzato, rimane un bene pubblico e non può essere oggetto di appropriazione privatistica. Modelli di collaborazione come i sandbox regolatori – spazi controllati di sperimentazione – possono favorire l’innovazione mantenendo la supervisione pubblica e la sicurezza dei cittadini.
Ricerca traslazionale e formazione scientifica
L’IA offre l’opportunità di rafforzare la ricerca traslazionale, cioè il ponte tra laboratorio e clinica. L’integrazione di big data biologici, genomici e clinici permette di generare nuove conoscenze e di trasformarle rapidamente in protocolli terapeutici. Le università italiane dovrebbero introdurre corsi interdisciplinari di “intelligenza artificiale per la salute pubblica”, formando figure ibride tra medicina, informatica, bioetica e statistica. Solo investendo in capitale umano sarà possibile garantire la sovranità scientifica dell’Italia nel campo della sanità digitale.
L’Italia nel contesto europeo e globale
L’IA è una questione geopolitica oltre che tecnologica. La capacità di un Paese di produrre, gestire e interpretare dati di salute definisce il suo grado di sovranità digitale. In Europa, diversi Stati membri hanno già avviato strategie nazionali dedicate: il Regno Unito con l’NHS AI Lab, la Finlandia con la National AI Strategy for Health, la Francia con il piano Health Data Hub, la Germania con il Digital Health Act.
L’Italia, con la forza del suo SSN universalistico e una rete capillare di infrastrutture sanitarie pubbliche, ha il potenziale per diventare un modello di IA per la salute equa e solidale, fondato sulla centralità del cittadino e sulla cooperazione europea. Partecipare attivamente all’EHDS significa non solo condividere dati, ma contribuire alla costruzione di un sistema di conoscenza collettiva continentale.
Sul piano globale, l’Italia può inoltre rafforzare la propria leadership nei forum multilaterali – OMS, OCSE, G7, G20 Salute – promuovendo una visione dell’IA sanitaria come bene pubblico globale, soggetto a regole comuni di equità, sostenibilità e diritti digitali.
Raccomandazioni operative per una strategia nazionale
Perché l’Intelligenza Artificiale diventi una componente strutturale del SSN, e non una somma di esperienze isolate, è necessario un quadro organico di azioni strategiche e operative.
Le principali raccomandazioni, coerenti con PNRR, Piano Triennale e EHDS, possono essere sintetizzate come segue:
1. Elaborare una Strategia Nazionale per l’IA in Sanità, entro il 2026, con obiettivi misurabili e indicatori di impatto;
2. Istituire la Cabina di Regia Nazionale per coordinare istituzioni, Regioni e stakeholder;
3. Rendere obbligatoria la formazione digitale per tutto il personale sanitario, integrando l’IA nei curricula universitari e nei programmi ECM;
4. Creare un Registro Nazionale degli Algoritmi Clinici, gestito dall’ISS, con accesso pubblico e valutazione indipendente;
5. Potenziare il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, assicurando interoperabilità, completezza dei dati e qualità informativa;
6. Promuovere progetti pilota regionali, in particolare nelle aree interne e marginali, per sperimentare l’IA come strumento di equità territoriale;
7. Garantire la sovranità dei dati, con infrastrutture cloud nazionali certificate e protocolli di sicurezza avanzata;
8. Integrare l’etica nei processi decisionali, attraverso valutazioni di impatto e comitati etici digitali;
9. Rafforzare la ricerca traslazionale, con fondi dedicati e partenariati pubblico–privati regolati;
10. Monitorare costantemente l’impatto dell’IA sul sistema sanitario, pubblicando report annuali di trasparenza e performance.
Conclusione
L’Intelligenza Artificiale rappresenta una svolta epocale per il Servizio Sanitario Nazionale. Se governata con visione, competenza e responsabilità, può rafforzarne i principi fondativi: universalità, equità, solidarietà. L’Italia ha le condizioni per diventare un laboratorio europeo di innovazione etica nella sanità digitale, trasformando la tecnologia in un’estensione della missione pubblica e non in una sua deviazione. La vera intelligenza, in sanità, non è quella delle macchine, ma quella delle istituzioni capaci di governarle nell’interesse collettivo.
Una sanità intelligente non è quella che automatizza, ma quella che comprende. Non quella che sostituisce l’uomo, ma quella che lo accompagna nella cura del bene più prezioso: la vita.
Riferimenti bibliografici e normativi
• Ministero della Salute, PNRR – Missione 6 Salute, 2024.
• AgID e Ministero della Salute, Piano Triennale per la Sanità Digitale 2024–2026.
• Commissione Europea, Proposal for a Regulation on the European Health Data Space (EHDS), Bruxelles, 2024.
• Parlamento Europeo, Artificial Intelligence Act (AI Act), 2024.
• OMS, Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health, Ginevra, 2021.
• OCSE, AI in the Health Sector: Balancing Innovation and Trust, Parigi, 2023.
• AIFA, Rapporto sull’Innovazione Farmaceutica e Digitale, Roma, 2024.
• ISS, Linee guida per l’uso clinico dei sistemi di intelligenza artificiale, 2025.
• WHO Europe, Regional Digital Health Strategy 2023–2030, Copenhagen, 2023.